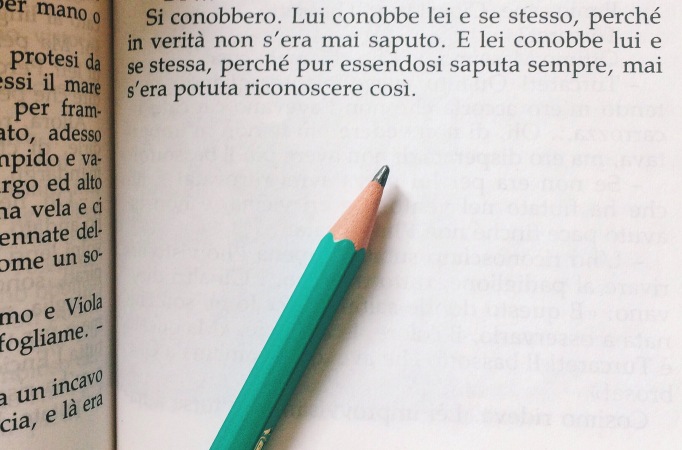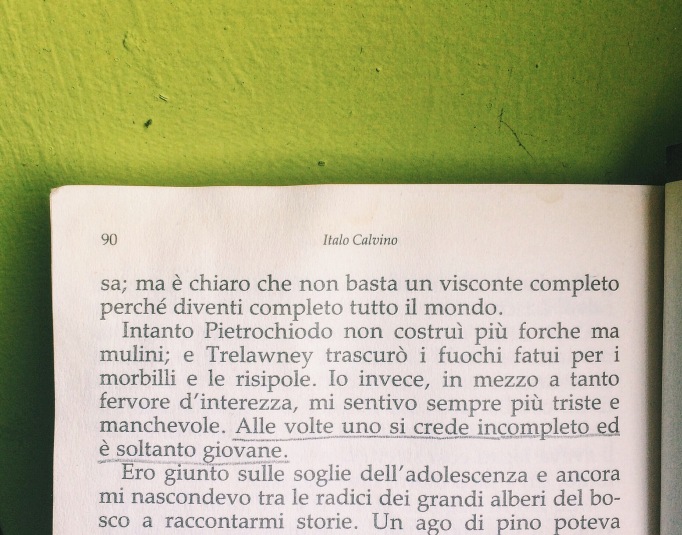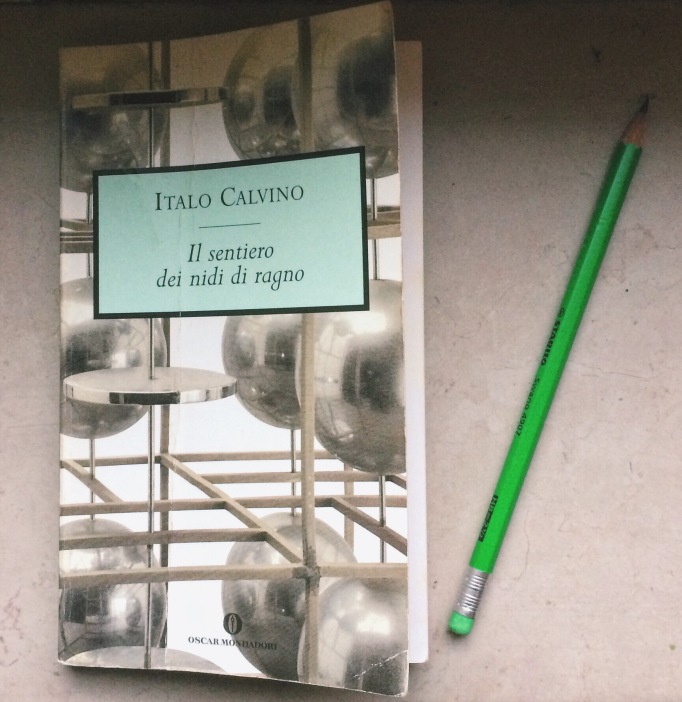Il 15 luglio 1974 la conduttrice americana Christine Chubbuck si uccise in diretta televisiva con un colpo di pistola. Il tragico gesto ispirò Quinto Potere di Sidney Lumet e quest’anno due film presenti al Torino Film Festival: Christine di Antonio Campos, in concorso, e Kate Plays Christine di Robert Greene, nella sezione Festa Mobile.
Due film che raccontano la stessa storia con modalità estremamente differenti.

CHRISTINE
Christine di Antonio Campos è un canonico biopic americano e racconta l’ultima parte della vita della Chubbuck, per svelare i retroscena del suo suicidio: l’ossessione insoddisfatta di raggiungere gli obiettivi professionali, il disprezzo per la televisione sensazionalista, l’assenza di esperienze amorose e sessuali, una profonda depressione.
Viene mostrato nel dettaglio il lavoro all’interno di una rete televisiva americana di provincia, attraverso l’aspro contrasto fra Christine, legata a un’etica incorruttibile, e il suo capo, disposto a cospargere lo schermo di sangue pur di accaparrarsi audience.
Il maggior punto di forza del film sta nella magistrale interpretazione di Rebecca Hall, che non a caso è stata premiata al Festival come miglior attrice. La Hall – attraverso un’acuta attenzione per i movimenti, i gesti, la mimica facciale – ha saputo rendere perfettamente le due anime che animavano la Chubbuck: da una parte una giornalista tremendamente ambiziosa e determinata, dall’altra una donna fragile e soffocata dalla depressione. Tutta la pellicola, a sua volta, gioca su questa continua alternanza tra momenti dinamici e scene drammatiche e introspettive, rispecchiando la nevrosi della donna. Tuttavia, molto del trascorso di Christine viene taciuto e con il procedere del film si dà sempre più importanza ai problemi psichici della protagonista piuttosto che alla sue ragioni etiche.
Al centro non c’è tanto il tratto biografico o l’evoluzione mediatica in negativo, ma l’ insuperabile estraneità della donna rispetto al mondo e agli altri esseri umani, una solitudine sofferta e obbligata.
Lo spettatore è costretto quindi a provare compassione per la protagonista e i suoi fallimenti e viene colpito dal tragico epilogo che, seppur noto, riesce a inquietare e commuovere.

KATE PLAYS CHRISTINE
In Kate Plays Christine Robert Greene abbandona completamente la struttura del biopic tradizionale e sceglie una struttura narrativa assai più complessa – e interessante – quella del docu-fiction.
Nel film, infatti, non vediamo la storia di Christine Chubbuck, ma la storia dell’attrice Kate Lyn Sheil che si prepara ad interpretare Christine (in un film che in realtà non esiste), in un’angosciante operazione di ricerca ed immedesimazione.
Di grande impatto emotivo il processo di metamorfosi a cui si presta Kate per somigliare al suo personaggio: indossa la parrucca, mette le lenti a contatto per cambiare il colore dei suoi occhi, scurisce la sua carnagione. E ad ogni passo Kate sembra sprofondare sempre di più nell’angoscia di Christine, nei suoi turbamenti.
La metamorfosi, infatti, non è solo fisica, ma anche emotiva: Kate visita i luoghi della vita di Christine, tra le strade e gli edifici di Sarasota, parla con le persone che le stavano intorno, ripercorre gli eventi e le situazioni vissute dalla donna, e sembra verificarsi sullo schermo una vera e propria sovrapposizione fra attrice e personaggio. In questo modo vengono rivelati diversi retroscena che nel bopic di Campos non trovano spazio.
Il film si presenta come un’esperienza intensa, fortemente angosciante e cupa, che si interroga sulla necessità di entrare nella pelle di un’altra persona per comprenderla a pieno. Ma è un’altra la questione fondamentale: il triste bisogno di guardare la tragedia, il sangue che scorre, la morte in diretta. Chi fra gli spettatori non ha desiderato, anche inconsciamente, guardare il video di repertorio che mostra il suicidio della Chubbuck? Ed è quello che sottolinea nel monologo finale Kate Lyn Sheil, intrappolata nella sofferenza della sua interpretazione ma terrorizzata dal suicidio, anche se solamente simulato. L’attrice ripete più volte ‘Why?’.
Perché abbiamo bisogno di vedere quel proiettile che attraversa la sua testa? Non è semplice rispondere.
Il senso di angoscia crescente è veicolato anche dalla colonna sonora, dalle tinte thriller, quasi horror; come dalle numerose incursioni della voce fuori campo di Kate, che racconta la sua difficile esperienza di immedesimazione, spingendo il pubblico a un forte coinvolgimento.
I due film dialogano e si completano, per chi li ha visti entrambi sembra quasi impossibile separarne la fruizione. Ma nessuno dei due dà risposte certe in merito a una vicenda che rimane misteriosa quanto inquietante, senza dubbio attuale e ricca di spunti di riflessione.
G.